Ovvero Il trionfo della scrittura barocca, esondante, maniacalmente ricercata.
Alfio Pelleriti
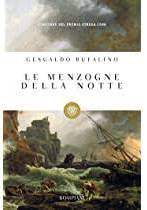
Un isolotto su cui si infrangono le onde alte sugli scogli, ospita usberghi maestosi che proteggono la severa semplicità di un castello trasformato in carcere. Dentro vivono carcerieri e detenuti quasi costretti in un unico destino a condurre il loro viaggio nella vita seppure con ruoli diversi ma che a volte sembrano interscambiabili. Bufalino si avvicina pian piano a tale realtà cruda, statica, orrida a tratti, come con un teleobiettivo, iniziando con un “campo totale, passando poi a un campo medio, fino al primo piano sui personaggi che abitano quell’ambiente in cui vivono uomini senza speranza di poter cambiare la loro vita grama di galeotti. E in un “piano sequenza” l’attenzione poi punta sulle celle, cominciando con l’”inquadratura” di due passeri che, “resi domestici e arditi, s’insinuavano attraverso le sbarre dentro le celle più amiche.”[1]
La prima osservazione che viene in mente al lettore di una qualsiasi storia di Gesualdo Bufalino riguarda la sua prosa che, necessariamente lo mette alla prova per definirla con parole adeguate, con concetti che non svaporino prima ancora di adagiarsi nello spazio ad essi assegnato per un commento, per una chiosa, per un azzardo di critica. Bisogna dire che la prosa dello scrittore comisano è molto particolare, e lo è tanto da azzardare che non è una prosa; né si può definire poesia, perché di questa non ne presenta i canoni formali, tuttavia il lettore è obbligato, per apprezzarne la scrittura, ad interpretarla leggendola a voce alta perché altrimenti non potrebbe coglierne la sonorità, né potrebbe apprezzarne la formidabile architettura che, come per le cattedrali gotiche, inizia ad essere ammirata dai possenti pilastri, dai “barbacani” che non hanno il compito di ergersi a difesa di attacchi di barbariche cavallerie, bensì a reggere l’amorevole, incontenibile afflato d’involarsi a puntuta guglia ad indicare l’infinito azzurro cielo.
Bufalino come un compositore, scrive su spartiti musicali da empire affidando ad ogni componente l’orchestra un compito, utile perché dell’opera si colga poi il risultato corale, che tocchi poi insieme mente e cuore e faccia da stimolo ad ogni ascoltatore perché s’unisca coi suoi sogni, infranti o ancora pulsanti, alla sublimità di un presente in cui quell’opera diventi arte.
E così, come avviene con la musica operistica, lì dove il libretto, la vicenda cioè da raccontare, è solo occasione e strumento perché il canto e la musica si uniscano ad estasiare i cuori degli spettatori, anche nei testi di Bufalino la vicenda non vuole focalizzare questioni storiche, sociologiche, psicologiche, ma è solo l’espediente perché si costruisca un mosaico perfetto, ove le tessere sono parole ed ogni sequenza ne rivela una parte, e occorre che il lettore si sposti un po’ indietro e inquadri il testo da lontano, perché ne possa apprezzare, in un campo totale, la bellezza. Un esempio tra i tanti: una cella ospita dei condannati al patibolo e l’alba li sveglia: “Li sveglia e il primo riverbero d’umido sole li sorprende sempre così con gli occhi al soffitto, metà imbrattati di sogni, metà di paura, intenti a tracciare fra le travi linee di forza e di fuga, un intreccio di svincoli, botole e crepe, alla fine dei quali, li attenda una felice assenza di peso, un’aerea dissennatezza, un sentimento di volo che nel loro idioma mentale, non scritto né detto, corrisponde all’idea, così virginea e sorgiva, di libertà.”[2]
Non meno interessante la vicenda presentata nel romanzo: i protagonisti sono cinque condannati al patibolo in attesa dell’alba del giorno nel quale consegneranno la loro testa al boia che si incaricherà di far scendere repente la lama che la farà rotolare nel cesto, così come avveniva nella Parigi giacobina, alla presenza d’una folla incuriosita, eccitata, plaudente. A meno che uno tra loro scriverà il nome del loro capo su un foglio per salvare a tutti la vita guadagnando un espatrio in Argentina.
Si narra della loro ultima notte che trascorreranno a raccontare, per una volta sinceri, la loro storia, non per passarla ad uno scrivano perché ne possa ricavare un qualche vantaggio o per edulcorare ciascuno la loro barbarica esistenza di briganti ma per trovare, frugando in se stessi, un episodio, un momento nel quale hanno provato la levità dell’essere felici; quell’istante cioè, in cui la pace interiore ti proietta oltre il tempo, facendoti cogliere l’eternità, emozione questa concessa solo agli umani, benché in pochi ne godano di solito, presi, il maggior numero, da faccende concrete, convinti ottusamente che non bisogna sprecare il tempo filosofeggiando, ma ad accumular denaro, ad ingozzarsi di sapide pietanze, a concedersi a beveraggi esaltanti seppur distruttori di senno, a soddisfare il corpo in tripudi di innumeri piaceri.
Quando la trama della narrazione diventa vieppiù eccitante e trasporta magicamente il lettore in avventure audaci nel romantico primo ‘800, intessute d’impavide azioni di giovani, nutrite da sentimenti d’amore per eteree bellezze e d’ideali luminosi per rendere una patria vilipesa alfine libera e bella, allora egli dice a se stesso che Bufalino fa onore alla terra di Sicilia e anche lui è da considerare grande tra i poeti e i romanzieri, come gli altri suoi conterranei, ammaliatore, affabulatore, artista con le parole e che merita certamente l’appellativo di classico, ove per classicità è da intendere la sua naturale abilità linguistica nel cogliere il Bello; è da intendersi, altresì, la forza istintiva di mostrare in immagini le essenze che stanno a fondamento dell’esistere. È per tale motivo forse che il romanzo rimane senza finale e le ultime venti pagine agiscono come una fitta nebbia che fa svaporare i contorni del paesaggio e le descrizioni diventano interminabili e vaghe, e volutamente il grigio diventa più spesso e invade la mente del lettore che invano attende l’esito della storia.
Sono questi, invero, i sentimenti che prova codesto lettore dopo aver “ascoltato” le storie di coloro che aspettano l’alba dell’addio alla vita.
[1] Gesualdo Bufalino, Le menzogne della notte, sta in Opere 1981-1988, Classici Bompiani, 1992, pag. 564
[2] Ibidem, pag. 567