Alfio Pelleriti
Philiph Roth pubblica nel 2001 “L’animale morente”, romanzo che fa parte di una trilogia, insieme a “Il seno” e “Il professore di desiderio”, che vede un unico protagonista, David Kepesh, professore sessantaduenne di critica letteraria che ha un debole per le sue allieve più procaci e disponibili ad avere rapporti intimi con lui. A tale scopo organizza feste a casa sua dopo la chiusura dei suoi corsi. Nonostante la mia perplessità alla lettura delle prime pagine, così come mi era accaduto con “Pastorale americana”, vado avanti, seguendo la vicenda umana del protagonista che si affanna a voler fermare il tempo con comportamenti tipici di un giovane vinto da tempeste ormonali che gli abbassano le capacità raziocinanti inducendolo a scelte radicali, come quella di lasciare moglie e figlio, per essere libero di soddisfare la sua pulsione sessuale, vera e propria “coazione a ripetere”.
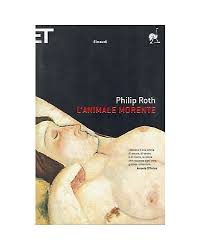
Immerso nel vortice di una predatoria ricerca di giovani donne per dimostrare a se stesso che vale e che piace, in una di tali feste conosce Consuela Castillo, una bella e formosa ragazza ventiquattrenne di origine cubana, con la quale intraprende una relazione a sfondo erotico. David ha alle spalle un matrimonio fallito, un figlio che incontrerà dopo quarantadue anni, durante i quali non ha sentito alcun rimorso morale, né ha affrontato alcun dubbio sulla sua vita votata all’edonismo e alla lussuria, considerando le donne alla stregua di oggetti utili per il soddisfacimento delle sue più basse pulsioni. E il romanzo procede, quasi fino alla fine della vicenda, descrivendo, con dovizia di particolari, tali incontri, non peritandosi l’autore di cadere spesso nel pessimo gusto, fino al pornografico.
È una sensazione sgradevole quella che provo di fronte ad un narratore che non si pone alcuna censura, dando alla sua prosa un taglio iperrealistico, appiattendosi su un radicalismo espressivo che sfocia spesso su aspetti grevi della realtà, o che attengono il terreno paludoso della quotidianità e della materialità, magari con l’intento di colpire il comune senso del pudore, come usava dire negli anni in cui la censura tarpava le ali agli artisti. Si avverte, insomma, in questo romanzo di Roth, un desiderio di andare oltre la normalità cercando la trasgressione quasi come fosse uno stimolo necessario alla sua creatività e segno ineludibile del suo tratto narrativo. L’azione dunque si svolge all’interno di un’atmosfera cupa che grava su Kepesh, intento a dare senso alla sua vita dandosi totalmente al suo patologico ed egocentrico consumo di sesso.
Nei suoi rapporti con le giovani donne non esiste alcun riferimento ad idealità o a sentimenti, né si avverte traccia di moralità, ma solo pulsioni ed istinti carnali non filtrati da convinzioni e convenzioni culturali, sociali, religiose. Si avverte solo una focalizzazione su desideri non sublimati, su materiale inconscio ancora grezzo, non elaborato, ma istintuale, primitivo, arcaico, violento, che lo scrittore butta lì, in faccia ai suoi lettori, per scandalizzarli forse, ironizzando sul senso comune o su comportamenti che vengono tacciati come ipocriti da chi si sente sempre più in alto di una spanna rispetto alle persone che lavorano, allevano con sacrifici i loro figli, si concedono una settimana di vacanza al mare e fanno la spesa presso il discount più economico.

Quella presentata nel romanzo è una squallida storia di un professore che passa da un rapporto a un altro con sue allieve più giovani di 30-40 anni, una dimensione, dunque, in cui il cielo è sempre grigio, un ambiente privo di vette, dove il terreno è sempre piatto e brullo, come una landa desertica inospitale, dove si passa repentinamente dal caldo al gelo delle notti e gli uomini, in tale grigiore, si illudono di vivere solo perché si danno ai loro giochi erotici e si accoppiano come conigli rispondendo ai loro istinti biologici, calpestando le altre dimensioni che dovrebbero connotarli come uomini.
Sì, in questo suo romanzo della maturità, lascia l’amaro in bocca lo scrittore americano, quando si dà a raccontare con dovizia di particolari le acrobazie erotiche di un professore che, giunto ai settant’anni, vuole ancora mettere al centro della sua vita la pura e semplice sessualità sfrontata d’ogni orpello contrattualistico (il matrimonio) o etico: “Sposarsi e avere un bambino sembrava anche a me, nel ’56, una cosa naturale. Non eri un uomo sessualmente emancipato, quando raggiungevi l’età adulta. Eri un ladro sessualmente parlando. La palpata la davi a tradimento. Lo rubavi il sesso. Blandivi, adulavi, imploravi, insistevi…per il sesso dovevi lottare, contro i valori, se non contro la volontà delle ragazze. Ecco perché dovevi imporle la tua volontà.”[1]
e ciò accadrà anche con Consuela, la sua preferita, di cui apprezza il turgido seno, che tuttavia dovrà essere deturpato dal chirurgo con una mastectomia, poiché le è stata diagnosticata una neoplasia grave, per la quale ha in corso un ciclo chemioterapico, che le causerà la caduta dei capelli. Consuela, dopo qualche anno di assenza, cerca il suo amante proprio per trovare in lui rifugio e un aiuto per affrontare la morte che incombe inesorabile sulla sua esistenza di trentaduenne.
È questo il romanzo più amaramente pessimista che mi sia capitato di leggere, e devo dire che tale modalità narrativa non mi ha coinvolto e i dubbi provati all’inizio della storia si sono trasformati vieppiù in sconcerto. E non basta chiudere questa storia, così squallida, con qualche pagina sulla morte di una giovane donna verso la quale il protagonista, finalmente, scopre qualcosa di diverso che l’attira oltre al suo corpo. Non basta, per uscire fuori dalla melma in cui si è sguazzato, citare solo alla penultima pagina la parola “spirito”. Troppo tardi, perché si possa definire “L’animale morente” di Philip Roth un “grande romanzo”, come si legge nel lapidario ed epigrafico giudizio di Antonio D’Orrico posto in copertina.
[1] Philip Roth, L’animale morente, Einaudi editore, Torino 2009, pag. 49