Alfio Pelleriti
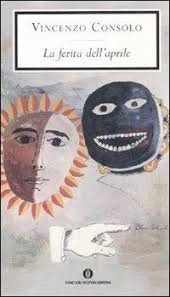
Come un artista surrealista che se ne frega di rispettare le forme del reale, crea Vincenzo Consolo, non scrive solamente! Prende le parole e le adagia lì sul foglio, e il senso, l’ordine, le pause sa lui come dosarli, sa lui come creare l’alchimia che alfin stupisce e incanta. Lì usa un’espressione presa dal suo gergo dialettale in uso a San Fratello, che conserva ancora le sue radici gallo italiche e la usa come fosse un’oliva niura in mezzo a due vocaboli alquanto rari, letterari, non comuni, dice la Treccani. Il suo non è un siciliano comune e in uso nel palermitano o nel catanese, è “zanglè”, “forestiero”, sarebbe, come dire… “lesanglè”. Dice “lancella”, non lancedda”, “fardale”, non “mantale”, “gicara”, non “cicara”.
“La ferita dell’Aprile” è il suo primo romanzo, pubblicato nel 1963. Si muove l’autore come nel genere autobiografico: sono dodici piccoli capitoli in cui Consolo racconta episodi dell’infanzia e dell’adolescenza incastonati in una Sicilia un po’ arcaica e a tratti barbarica, inseriti come fosse all’interno d’una cornice che separa da altre realtà. A tale scopo usa solo colori e volti particolari; s’avvale di ordini e simmetrie e poi si perde in discrasie, in entropie tipiche d’una terra che da sempre fa della contraddizione e della coesistenza degli opposti, la sua essenza, il suo fondamento, e dunque la sua intrinseca labilità e debolezza.
Già da questo suo primo romanzo emerge una caratteristica che diventerà poi, nel “Sorriso dell’ignoto marinaio”, in “Retablo”, ne “Le pietre di Pantalica” o “Di là del faro”, una costante: la musicalità, cioè, quell’armonia d’una prosa che contiene accordi che scopri nel bel mezzo della sequenza, mentre sospendi il tono, seguendo il ritmo della costruzione sintattica, per approdare alla chiusura che riprende, con la sua assonanza, un vibrante labiale o una tronca che avevi lasciato in attesa al primo rigo. E scopri perfino frasi composte da endecasillabi: “Sul punto ch’era l’ora di mangiare, facevano il concerto di buatte, schierati a uno a uno lungo il muro.”[1] No, questa non è prosa, meglio sarebbe definirla una “pittura”! E a riprova, ecco come presenta dei giovani pescatori usciti la notte in barca alla lampara: “E’ alba per loro questo tramonto, poi si fa notte, scura: la luna piena dice fame ai pescatori, offusca le lampare. Non sanno altro tempo fuori che questo, come le farfalle, i pipistrelli. Hanno mai visto l’argento delle sarde delle alici e l’oro delle triglie? Le sanno bianche, biancastre, alloppiate sotto le lampare; conoscono le squame sotto le dita ed il sapore, il profumo, ad arrostirle sul piatto infuocato delle luci.”[2] E poi, ancora, intere sequenze in rima con “mattina – Argentina – con vestina”; e poi “battaglio” con “maglio” e “bagna” con “lavagna”.

Gli episodi che vedono protagonista Scavone (l’io narrante) si svolgono nel secondo dopoguerra, gli anni della formazione dell’autore, dei suoi incontri e delle sue prime esperienze amorose e vi si trovano insieme riferimenti storici, sociali o eventi naturali che colpirono il giovane autore: “L’eruzione del quarantasette fu schifosa, vigliacca! Dirò ai figli miei. L’anno che ci fu l’elezione e Giuliano dormiva negli alberghi di Palermo.”[3]
E poi si va avanti, di immagine in immagine, di ricordo in ricordo, come fossero dei frame, dei fotogrammi che s’affollano alla mente, mentre un ricordo preme sull’altro a farsi strada, e Consolo non se li fa scappare, regge la briglia, frena la veemenza del suo cuore. Sono tutti lì, tutti in sequenza e non ha tempo di curarli o d’addolcirli con l’eloquio che si specchia in Arno, con logica struttura, con elegante periodare, perché tutti son da salvare quei momenti di vita trascorsi con gli amici d’infanzia, con lo zio, che gli fece da padre quando quello naturale lo lasciò anzitempo. Sono momenti d’un passato che brillano sebbene ognuno col suo colore dominante; sono immagini che Consolo passa ai suoi lettori, come le “piccole cose di pessimo gusto” di cui erano pieni i ricordi di Guido Gozzano, il poeta decadente: “… la contessa è presa d’altre idee, come questi che girano il paese con le macchine a gridare oggi alle sedici parla Cipollaro, cittadini, Aprile e Maggio alle diciotto, attenzione… Marì Campisi è felice a passeggio con suo padre, vestito di celeste. Marì mastica e non inghiotte mai, le labbra rosse in movimenti larghi, da fare impressione pure ai vecchi. Al casino leggono il giornale chiuso nel bastoncino chiuso col lucchetto, la radio fa sentire la voce della lava e il rantolo dell’albero che si contorce e muore… sul muretto un uomo con un uomo dice ad un gruppo che gli si presenta, compagni, il compagno Gerolamo La Fauci…”[4] Questa sequenza che per me è una poesia, per la critica Claudia Consoli, redattrice del blog CriticaLetteraria è “una lingua intrisa di oralità, si nutre di canti liturgici e popolari, di scanzonate rime dialettali, interiezioni e modi di dire.” Tutti dati pre-diegetici, conclude. Saranno pure “pre-diegetici” queste sequenze di Consolo, che per me bisognerebbe chiamarlo poeta non scrittore, o pittore, magari. Sì, perché la sua prosa è musicale, dicevo, ha ritmo e presenta quadri con tinte ora tenui, che solo accarezzano le pagine, ora forti che emanano calore; una prosa che dona una serenità che molce il cuore, una gioia sottile che fa scendere una lacrima che t’attraversa il viso, ‘che quella immagine evocata con quelle precise pennellate ti spingono alle stagioni andate, all’allegria innocente, ai sentimenti veri, e dunque, lo ringrazi Consolo per i suoi “versi” che ti ricordano un Aprile del Cinquanta: “la conca che s’appende nel dammuso”, “la voglia d’insalata sul terrazzo”, “i vecchi, lo scialle nelle spalle e le coppole sugli occhi”, “le donne che ripassano i capelli, fino alle spalle e conservano i batuffoli nelle crepe”, “i centrini a punto croce”, “i cappelli di giornale, i trespidi e le tavole…”[5] e infine non voglio tralasciare la descrizione che fa pensare al mio presente, non solo a quel che fu: è un giudizio politico, o morale, se volete, che riguarda i piccolo-borghesi che tronfi e sorridenti vanno ogni sera al circolo dei civili: “questi quattro civili proprietari ci hanno una fame di liquido in contanti, ti danno il fiore come niente, basta non aver pensiero a venti, scirocchi e grandinate, in pace stare dentro il casino a leggere il giornale, giocare, tressette e zecchinette, o a casa loro sopra le poltrone.”[6]

Poi cambia improvvisamente il suono, ma il quadro è ancora lì coi suoi colori: “Del temporale che minacciava nulla rimane, solo questo russare quieto e profondo, come nei meriggi estivi il mare nella grotta.”[7] E buttata lì, come fosse cosa tra le cose, la disperazione dei poveri, dei pescatori e dei contadini che s’abbrutivano di lavoro malpagato per dare un destino diverso dal loro ai figli, invano, e al rettore dell’Istituto delle suore che aveva espulso il figlio, così espresse tutta la sua rabbia il padre del suo caro amico Filippo: “Parlando parlando, nel corridoio s’alzarono le voci, e gli disse il signor rettore: ‘Vada via, faccia il favore!’ – ‘No, non ce l’ho con voi’ gli rispose il padre di Filì. ‘Me la piglio coi governi che non hanno messo le scuole nei paesi’.”

Consolo in questo suo affresco della Sicilia del secondo dopoguerra li mette in primo piano i poveri e gli sfruttati, non si lascia andare ad un romanticismo di maniera, o ad analisi sicilianiste sulle politiche oppressive e di rapina dei governi postunitari che avrebbero impedito lo sviluppo della solida produttività dell’isola avviato già dai Vicerè spagnoli e dal lungimirante e dinamico notabilato siciliano e sostenuto dagli illuminati governi borbonici. Tali “falsità storiche” non trovano spazio in questo romanzo, che invece è un realistico esame d’una realtà dura per le classi popolari, sulle quali ha sempre pesato il giogo dei potenti, dei mafiosi, dei massoni, delle congreghe politiche e affaristiche.
[1] Vincenzo Consolo, La ferita dell’aprile, Oscar Mondadori, Milano 1989, pag. 53
[2] Ibidem, pag. 59
[3] Ibidem, pag. 68
[4] Ibidem, pag. 68
[5] Ibidem, pag. 71
[6] Ibidem, pag. 73
[7] Ibidem, pag. 87